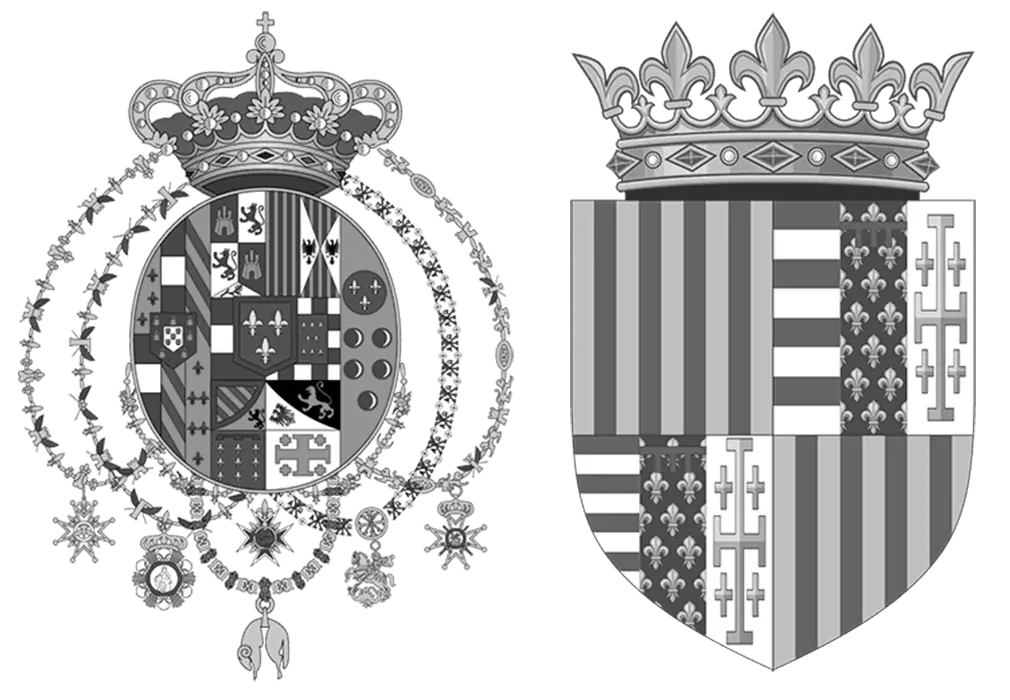Il 29 luglio non è un giorno qualunque per chi ama la natura e si preoccupa per la sopravvivenza delle specie selvatiche. In questa data si celebra, ogni anno, la Giornata Mondiale della Tigre, un’occasione per riflettere sul destino di uno degli animali più maestosi e affascinanti del nostro pianeta. La tigre, simbolo di potere e mistero, è oggi una specie in pericolo critico, la cui sopravvivenza dipende sempre più dall’impegno collettivo della comunità internazionale.
L’idea di istituire questa giornata è nata nel 2010, in occasione del Vertice della Tigre di San Pietroburgo, in Russia, dove i leader dei tredici Paesi in cui le tigri vivono ancora in libertà hanno lanciato una dichiarazione ambiziosa: raddoppiare la popolazione mondiale di tigri entro il 2020. Un obiettivo audace, carico di speranza, ma anche estremamente complesso, che ha messo in moto una rete di collaborazioni tra governi, scienziati, organizzazioni ambientaliste e cittadini consapevoli.
A distanza di anni, il cammino è ancora lungo. Nonostante alcuni successi locali, il numero complessivo di tigri selvatiche resta molto al di sotto dei livelli di sicurezza. Secondo le ultime stime, ne sopravvivono poco più di 3.900 esemplari in natura. Un dato allarmante se si pensa che all’inizio del Novecento si contavano oltre 100.000 tigri selvatiche. Oggi, i principali nemici della tigre non sono solo le armi dei bracconieri, ma anche i bulldozer dell’urbanizzazione, le conseguenze della crisi climatica e il silenzio dell’indifferenza.
La Giornata Mondiale della Tigre viene celebrata in molte parti del mondo, anche in Paesi dove questi felini non sono presenti in natura. In Bangladesh, Nepal e India, si tengono eventi pubblici, marce simboliche, programmi educativi nelle scuole e attività di volontariato nelle riserve. Ma anche in luoghi lontani, come l’Inghilterra o gli Stati Uniti, si organizzano manifestazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica. Celebrità e influencer, negli ultimi anni, hanno scelto di sostituire la propria immagine del profilo social con quella di una tigre, un piccolo gesto simbolico per attirare l’attenzione sul tema. A volte basta un’immagine per generare una riflessione, soprattutto nel mondo digitale.
Ma perché è così importante proteggere le tigri? Non si tratta solo di evitare l’estinzione di un’icona della fauna mondiale, ma di garantire l’equilibrio di interi ecosistemi. La tigre è un predatore al vertice della catena alimentare: la sua presenza è indicativa della salute dell’ambiente in cui vive. Proteggere la tigre significa, quindi, proteggere le foreste, i fiumi, le specie vegetali e animali che coesistono nel suo habitat. È un investimento sulla biodiversità, ma anche sulla nostra stessa sopravvivenza.
Le minacce, però, sono molteplici e tutte molto gravi. Il bracconaggio è ancora una delle piaghe più difficili da estirpare. Ogni parte del corpo della tigre – dalle ossa alla pelle, dai denti agli artigli – viene utilizzata nella medicina tradizionale asiatica o venduta illegalmente sul mercato nero. Questo commercio illegale è alimentato dalla domanda e sostenuto da reti criminali che operano a livello internazionale.
La perdita di habitat è forse la minaccia più subdola. Con la crescita della popolazione umana e l’espansione delle attività agricole e industriali, le foreste si riducono drasticamente. Si stima che il 93% degli habitat naturali delle tigri sia andato perso. Senza territori ampi, ricchi di prede e protetti, le tigri non possono sopravvivere. Sono animali solitari, che necessitano di vasti spazi per cacciare e riprodursi.
Il cambiamento climatico è un’altra bomba a orologeria. Nell’area delle Sundarbans, una delle più importanti riserve per le tigri del Bengala, l’innalzamento del livello del mare minaccia di sommergere l’habitat. Si tratta di una regione costiera di mangrovie tra India e Bangladesh, unica nel suo genere. La sua scomparsa significherebbe la perdita irreversibile di una delle ultime roccaforti naturali della tigre.
C’è poi il problema delle malattie. Alcuni studi, come quelli condotti dal Wildlife Institute of India, hanno evidenziato una crescente perdita di diversità genetica tra le tigri della Ranthambore Tiger Reserve. Questo le rende più vulnerabili a epidemie e patologie che possono rapidamente decimare intere popolazioni. La scarsa variabilità genetica è il risultato di un isolamento forzato, causato dalla frammentazione degli habitat, che impedisce alle tigri di migrare e incrociarsi con altri gruppi.
Il degrado dell’habitat, causato da attività umane anche all’interno delle aree protette, continua a compromettere la sicurezza dei grandi felini. Strade, impianti industriali, insediamenti umani e turismo non regolamentato disturbano profondamente l’equilibrio degli ecosistemi. Le tigri hanno bisogno di tranquillità e spazi incontaminati per vivere. Ogni forma di disturbo costante può spingerle ad abbandonare un territorio o entrare in conflitto con l’uomo.
E proprio il conflitto uomo-animale è un altro nodo irrisolto. Quando le tigri si avvicinano ai villaggi per predare bestiame, spesso vengono uccise in ritorsione. Dall’altro lato, anche gli uomini perdono la vita nei rari ma tragici casi di attacchi. È essenziale lavorare su politiche di prevenzione, risarcimenti tempestivi, creazione di corridoi ecologici e programmi educativi per promuovere la convivenza.
Non va dimenticato il ruolo positivo della Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate (CITES), che regola il commercio di animali e piante selvatiche. Le restrizioni imposte da CITES hanno contribuito a frenare il mercato illegale, ma è necessaria una maggiore cooperazione internazionale per renderle veramente efficaci. Le leggi da sole non bastano: servono controlli, investimenti, consapevolezza pubblica.
Ma cosa possiamo fare, concretamente, da cittadini, da europei, da italiani? Anche se le tigri non vivono nei nostri boschi, la responsabilità non conosce confini geografici. Il primo passo è informarsi, leggere, studiare, approfondire. Solo così possiamo diventare moltiplicatori di consapevolezza. Parlare delle tigri a scuola, in famiglia, sui social, è un modo semplice ma potente per diffondere il messaggio.
Si può poi sostenere le organizzazioni che operano sul campo, come il WWF, l’IFAW o lo Smithsonian Institute, che portano avanti progetti concreti per la protezione degli habitat, il contrasto al bracconaggio, la ricerca scientifica e il monitoraggio delle popolazioni selvatiche. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Inoltre, è possibile adottare simbolicamente una tigre, ricevendo aggiornamenti regolari sul progetto e contribuendo alla sua salvaguardia.
Un’altra forma di aiuto è quella legata al consumo responsabile. Evitare prodotti provenienti da aree disboscate illegalmente, scegliere carta e legname certificati, ridurre l’uso di carne e derivati di origine animale, sono tutte scelte che riducono la pressione sugli ecosistemi. La nostra spesa quotidiana può influenzare la sorte di una tigre a migliaia di chilometri di distanza.
Infine, c’è il potere dell’arte, della cultura, della narrazione. Film, documentari, fotografie e persino la letteratura possono dare voce a chi non ha voce. Le tigri possono diventare simboli potenti, capaci di emozionare e mobilitare. Celebrare la loro giornata non significa solo guardare una bella immagine, ma chiedersi che mondo vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi.
In un tempo in cui tutto corre, in cui le priorità sembrano sempre altre, fermarsi per pensare a un animale in via di estinzione può sembrare un lusso. In realtà, è un atto di responsabilità profonda. Le tigri ci parlano del nostro rapporto con la natura, dei nostri errori e delle nostre possibilità. Ci ricordano che ogni specie perduta è una parte di noi che se ne va.
Il sogno di raddoppiare il numero di tigri entro il 2020 non si è realizzato nei tempi previsti, ma non è stato vano. Ha innescato un movimento globale, ha messo la tigre al centro dell’agenda ambientale, ha acceso i riflettori su una sfida che riguarda tutti. E finché ci sarà chi lotta, chi educa, chi resiste, la tigre potrà ancora ruggire.