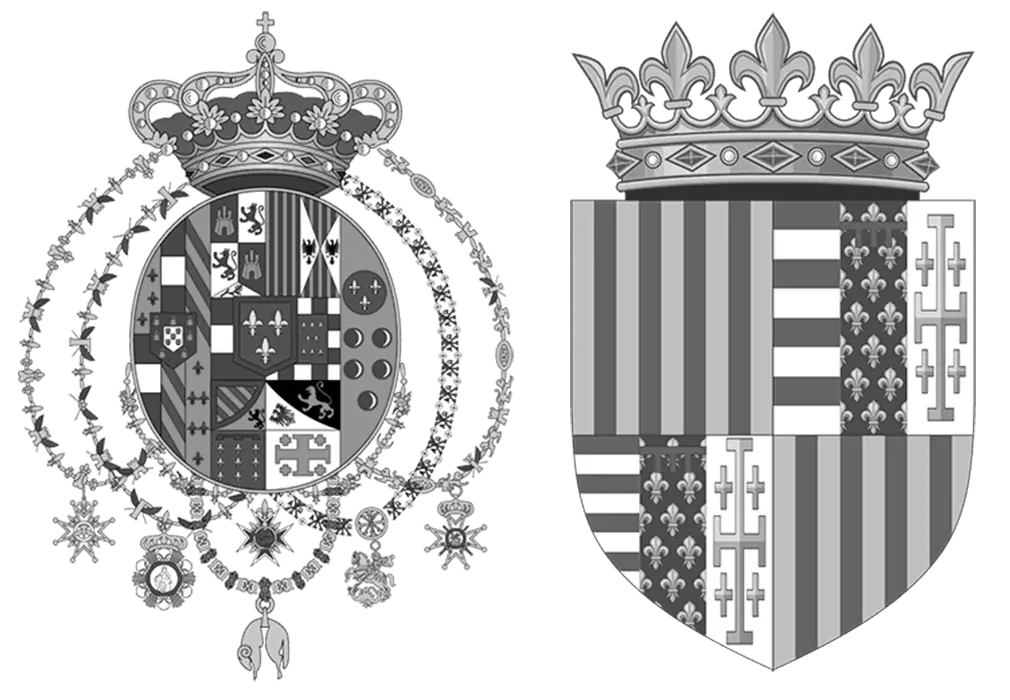Ogni anno, il 19 agosto, il mondo si ferma un momento per ricordare, onorare, e ringraziare chi ha fatto dell’aiuto umanitario la propria vocazione. La Giornata Umanitaria Mondiale, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, non è solo una data simbolica nel calendario internazionale, ma un invito pressante alla coscienza collettiva. È il giorno in cui si celebra l’impegno silenzioso e coraggioso di operatori e volontari che, in tutto il mondo, mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Uomini e donne che operano nelle zone di guerra, nei campi profughi, tra le rovine lasciate da terremoti, uragani, carestie e pandemie, portando non solo cibo, acqua, cure mediche e istruzione, ma anche speranza. E la speranza, in certi contesti, può essere l’unico strumento di sopravvivenza.
Il 19 agosto 2003, un terribile attentato colpì il quartier generale delle Nazioni Unite a Baghdad, uccidendo 22 persone, tra cui Sergio Vieira de Mello, rappresentante speciale per l’Iraq. Da quella tragedia è nata la consapevolezza che chi si occupa di missioni umanitarie non è sempre protetto dalla neutralità della sua missione, anzi: spesso è proprio preso di mira. Da allora, si è sentita l’urgenza di riconoscere pubblicamente questi sacrifici, e soprattutto di tutelare chi opera in prima linea. Ecco perché, cinque anni dopo, le Nazioni Unite hanno istituito ufficialmente la World Humanitarian Day, per ricordare non solo le vittime di quel giorno, ma anche tutti coloro che hanno perso la vita, sono stati feriti, rapiti o detenuti nell’esercizio del loro aiuto.
Da quel 2003, le statistiche raccontano una realtà drammatica: oltre 4.000 operatori umanitari sono stati uccisi, feriti o sequestrati. Una media che supera i 300 casi all’anno, quasi uno al giorno. Un bollettino di guerra che riguarda chi, invece, la guerra la combatte con gesti di solidarietà. Solo nel 2018, si sono registrati 369 attacchi contro umanitari, tra cui rapimenti, violenze e omicidi. Eppure, ogni anno, migliaia di persone decidono di partire, di donare tempo e competenze, di affrontare l’incertezza, la povertà, la disperazione, per dare una mano a chi è rimasto indietro.
La forza della solidarietà è ciò che rende questi gesti possibili. Ma non si tratta solo di eroismo. Si tratta anche di scelte politiche e sociali. Di finanziamenti internazionali. Di reti di collaborazione tra governi, ONG, organismi sovranazionali. Senza questo supporto, l’aiuto umanitario diventa impossibile, o peggio, mortale. La Giornata Umanitaria Mondiale ha dunque un doppio valore: da un lato celebrare e ricordare; dall’altro sollecitare l’opinione pubblica, i media, i decisori politici, affinché i diritti di chi aiuta e di chi è aiutato non vengano messi da parte.
Ma che cosa possiamo fare, concretamente, noi che viviamo lontani dalle zone di crisi? La risposta più sincera è: informarci. La consapevolezza è il primo passo. Conoscere le storie, i dati, i contesti. Capire dove, come e perché si interviene. Leggere le testimonianze. Condividere. E, laddove possibile, donare, aderire a campagne, sostenere progetti. Anche piccole somme, o poche ore del proprio tempo, possono cambiare radicalmente il destino di una comunità. Non pensiamo che le nostre scelte siano irrilevanti: ogni comportamento consapevole, ogni parola che diffonde conoscenza, ogni gesto di empatia è già un contributo alla causa umanitaria.
Oggi, ad esempio, molti bambini nel mondo non hanno accesso all’istruzione di base. Altri non hanno acqua potabile. Altri ancora vivono sotto le bombe o nei campi profughi, senza cure mediche adeguate. In questi scenari, l’intervento degli operatori umanitari è decisivo. In certi villaggi africani, l’arrivo di una sola volontaria può significare la sopravvivenza di un’intera generazione. Nelle zone colpite da epidemie, la presenza di personale sanitario umanitario è la linea sottile tra la vita e la morte.
Il lavoro di chi presta aiuto umanitario è anche una questione di dignità. Non si tratta solo di offrire soccorso, ma di riconoscere nell’altro un essere umano con diritti, speranze, sogni. L’approccio umanitario si basa sull’imparzialità, sull’indipendenza e sulla neutralità. Chi aiuta non giudica. Non chiede da che parte stai, che religione hai, da dove vieni. Aiuta, e basta. Questo tipo di etica dovrebbe essere un faro anche nella nostra vita quotidiana, nei gesti più semplici.
Viviamo in un mondo dove la disuguaglianza globale è sempre più visibile. Le crisi si moltiplicano, i conflitti non finiscono, le catastrofi naturali aumentano, anche a causa dei cambiamenti climatici. Il bisogno di aiuto cresce. E spesso, paradossalmente, proprio mentre la domanda cresce, l’attenzione cala. I media parlano di meno delle emergenze croniche, di quelle guerre dimenticate, di quei popoli in fuga da anni senza una patria. E allora, la Giornata Umanitaria Mondiale ci ricorda che non dobbiamo abituarci al dolore altrui. Non dobbiamo far finta di nulla.
C’è anche un aspetto di gratitudine che riguarda ognuno di noi. In un mondo dove milioni di persone vivono nella precarietà, nel pericolo o nella fame, il fatto di vivere in un paese in pace, con accesso all’istruzione, alla sanità, alla libertà personale, non è scontato. Dovremmo ricordarcelo ogni giorno. E magari, proprio ogni 19 agosto, dirci che abbiamo il dovere morale di restituire qualcosa. Anche solo un pensiero. Anche solo un grazie.
In definitiva, la Giornata Umanitaria Mondiale non è una celebrazione come le altre. È una chiamata alla coscienza, una sfida al nostro egoismo, una spinta alla nostra empatia. Ci mostra che l’umanità è una rete e che, se un nodo si spezza, tutta la rete perde forza. Non possiamo salvare tutti, certo. Ma possiamo evitare l’indifferenza. E questo, oggi, è già un gesto eroico.